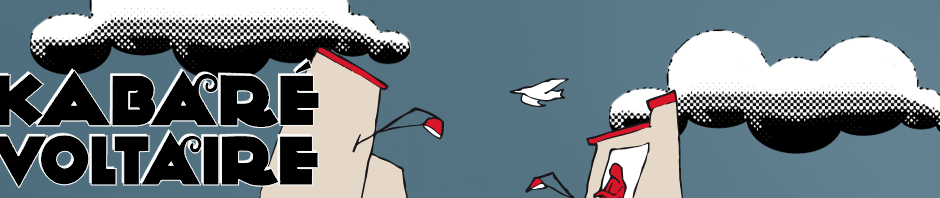Ogni tanto ricapito qui, sapete?, e seleziono un articolo a caso dalla barra di destra: un anno e un mese a caso, giusto per controllare cosa avessi scritto in quel periodo e se mi ricordi qualcos’altro. La sensazione è, propriamente, quella che si chiama nostalgia, ossia il “dolore del ritorno”. Ad ogni viaggio verso il passato, vengo assalito da una serie di rimpianti, di cose che avrei potuto, di cose che avrei voluto… Ogni cosa scritta è una specie di piccolo quadretto sfocato che non assomiglia più tanto alle cose che avevo in mente di dire. Il dolore è tutto lì: nella constatazione che molte e molte energie sono andate e, secondo le leggi della termodinamica, non c’è modo di riportarle indietro.
Adesso sto scrivendo altre canzoni, suono ancora e scrivo ancora e, per il solo fatto che le cose non vengano puntualmente documentate su un social, non è detto che non accadano. In quest’ultimo anno, per esempio, vi avrei scritto di questa graduale degenerazione a cui abbiamo tutti assistito: violenza verbale e risse da bar che, un tempo, mi avrebbero offerto moltissimi spunti per scrivere nuovi post. Ora, invece, mi danno un po’ di disgusto: se avessi dovuto documentare ogni piccolo spostamento verso il basso del livello del dibattito pubblico, ogni piccola forzatura della nostra moralità e della nostra umanità, avrei scritto molto e avrei, allo stesso tempo, sofferto molto, constatando che ciò che si scrive non sposta di una virgola lo sdegno e il disgusto di chi già lo prova e non provoca il minimo ripensamento in chi è convinto di essere nel giusto. Ecco: una caratteristica di questi tempi è l’irrigidimento. Nessun passo indietro, da parte di nessuno. Alla fine, avete sempre tutti ragione e questi sono tempi troppo difficili per la mia congenita insicurezza.
Tuttavia, il giorno della memoria è legato anche a questo, al dovere di esserci e di dire qualcosa, per quanto possa suonare retorico e scontato. La mia idea iniziale era quella di fare una piccola pubblicazione di tutti i post che avevano a che fare con il giorno della memoria e con il tema del ricordo. Ho cominciato a selezionarli – con un po’ di nostalgia – ripercorrendo tutto l’ultimo decennio. Ho riletto cose scritte anni fa e le ho trovate tutte molto simili. Volevo contestualizzarle e spiegare perché avevo scritto quegli articoli e mi sono reso conto che gli episodi ritornano uguali a distanza di tempo: nel 2014, alcuni nazisti avevano inviato teste di maiale ad una giornalista di famiglia ebraica; il 24 gennaio 2020, a Mondovì, altri buontemponi hanno scritto juden hier sulla porta di una famiglia di ebrei. Ripetitività? Alla fine tutto rimane uguale? Anche questo è uno degli inganni della memoria e, forse, avrei scritto anche qualche anno fa che eravamo inevitabilmente peggiorati. Nel frattempo però siamo diventati più insensibili ad una certa beceraggine: i fascisti possono definirsi tali senza finire in galera, possono protestare se viene loro tolto il diritto di esprimere le loro opinioni sui social, dimostrando – nonostante siano dei nostalgici pure loro – di avere una memoria decisamente selettiva su certi aspetti della dittatura. Il fascismo in generale (o, se volete, un certo cinismo sociale) è diventato uno dei modi di affrontare la contemporaneità: ci sono persone che pensano e dicono cose fasciste ma non le percepiscono come tali. Non gridate “al lupo, al lupo” senza motivo – ci intimano dalla tv: il lupo, in effetti, siamo noi e la nostra stolida volontà di difendere lo stato delle cose. Io però sono diventato più vecchio e, come potete intuire dalle righe precedenti, più intollerante nei confronti di questa continua messa in discussione dei nostri valori fondamentali: non sopporto i lupi, non credo che siano una conseguenza inevitabile dei tempi e non credo nemmeno che sia auspicabile usarli per difendere la mia casetta.
Qui di seguito allora vi metto una piccola selezione di cose che ho già scritto e che, magari, rilette, possono chiarire meglio quello che intendo con nostalgia e inganno della memoria. Soffriamo probabilmente proprio perché abbiamo la sensazione di ritornare sempre nei soliti luoghi comuni:
La scoria infinita (2009) Memoria ram(inga) (2011)
Si stava meglio (2013) La memoria del Furby (2014)
La diga della memoria (2014) All by my selfie (2015)
Memorie a perdere (2016) Resistenza & pazienza (2017)
A questo giorno io sono sempre stato molto affezionato. L’ho scritto tante volte: era il compleanno di mia nonna e quest’anno sarà la prima volta, per me, in cui lei non ci sarà. Se n’è andata in ottobre, talmente sazia di giorni che non mangiava quasi più e mi parlava con gli occhi. Negli ultimi tempi si sforzava di bisbigliarmi delle cose ma io non la capivo. C’era stato un weekend in cui avevo paura che morisse: ero andato a trovarla al sabato e poi ero tornato il giorno dopo con le mie figlie. Mi aveva guardato e poi mi aveva bisbigliato: “sto male così vieni a trovarmi più spesso”. Io avevo sorriso e anche lei: ci teniamo più strette le cose proprio quando stiamo per perderle.
Adesso ho una foto di mia nonna appesa sopra alla scrivania. Non credo che le assomigli tanto: è mia nonna a 91 anni ma io me la ricordo quando ne aveva 60 o 70. Me la ricordo che era forte e si alzava alle 5 della mattina e preparava le lasagne e il caffè quando arrivavano all’alba i nostri cugini dalla Svizzera. Me la ricordo che trasporta carrette piene d’erba o dà da mangiare ai conigli e alle galline. Tutta mia nonna non ci sta in una fotografia e questo credo che valga per ogni tessera della nostra memoria.
Forse il vero inganno della memoria, e del giorno della memoria, è proprio questo: affidare i nostri ricordi a dei piccoli quadretti, appenderli al muro e non pensarci più, finché sfumeranno nel tempo i lineamenti che volevamo ricordare. Si impolvereranno, prima o poi, e qualcuno proporrà di staccarli e tutto il tempo non sarà servito a niente. Forse dovremo pensare un po’ a quello che c’è dietro alle fotografie, alle persone reali che si sono incamminate per un destino assurdo, agli altrettanto assurdi ordini che hanno ridotto a zero la nostra umanità. Persone, persone vere che magari qualcuno ha tenuto appese al muro finché le foto non sono sbiadite.
Forse dei ricordi di tutti, compresi i miei, c’è solo una cosa che resta davvero.
Quello che resta, alla fine, sarà tutto l’amore consumato: quello che abbiamo ricevuto, quello che abbiamo impiegato per fare le cose, sarà tutto il dolore dietro una fotografia o qualche riga scritta in fretta, tutta la frustrazione che sta dentro una canzone. Sarà – ancora una volta – mia nonna che mi dice di avere pazienza e prendere le cose per l’amor di Dio. Sarà il mio diventare vecchio pensando a tutte le persone che mi hanno aiutato a crescere in tutto questo tempo.
Il ritorno ai ricordi allora non sarà così doloroso. Sarà ritrovarsi in quelle piccole zone luminose dove abbiamo deciso cosa diventare: sarà prendere un po’ di coraggio – anche quest’anno, come tutti gli anni – per fare altre cose, cambiare e decidere di guardare avanti.